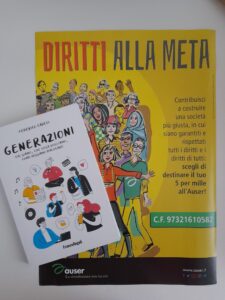“’Ncima un monte ce sta un cardu,// porta l’occhi come un fargu,// la camiscia verde e nira,// gran
dottò chi ce ‘nduvina//”. Questo indovinello, diffuso come tanti altri nelle campagne marchigiane,
oggi non lo scioglierebbe neppure un gran dottore. Proverbi, indovinelli e modi di dire erano il
modo abituale tra i contadini di tramandare le conoscenze prima che arrivassero le scuole:
stimolavano la curiosità dei bambini e ne potenziavano lo spirito di osservazione. In questo caso la
fantasiosa ed efficace descrizione si riferisce ad una pianta del tutto scomparsa nelle nostre
campagne: il lino. Insieme alla canapa, anch’essa non più coltivata, rappresentava una
importantissima risorsa per l’economia agricola mezzadrile che si basa principalmente sulla
produzione di quei generi che garantiscono l’autosufficienza. Se il grano, il mais e i legumi
soddisfacevano le necessità dell’alimentazione, questi prodotti garantivano la disponibilità di fibre
tessili per le manifatture domestiche. Ma mentre la lana, come il grano, abbondava nelle case dei
ricchi, la gente doveva accontentarsi di panni ruvidi e grossolani come le tele grezze casarecce, i
rigatini, i guarnelli di accia.
Il lino è una pianta simile a quella del grano ma con fusto più legnoso, foglie sottili grigioverdi,
fiori azzurri e semi ovoidali rossicci. La canapa ha ugualmente un fusto sottile e legnoso ma è molto
più sviluppata in altezza.
Queste due piante, e soprattutto il lino, sono state coltivate nelle campagne marchigiane fin dal
Medioevo, tanto che negli Statuti comunali delle singole città sono molte le prescrizioni che le
riguardano. Per ricavarne la fibra, infatti, entrambe debbono essere sottoposte a lavorazioni che
venivano considerate pericolose per la salute pubblica. I loro fusti, raccolti in mazzi, debbono essere
messi a macerare per diversi giorni nell’acqua stagnante. Estratti, vengono posti ad asciugare al sole
appesi ai pagliai o appoggiati ai muri di casa. Si procede quindi alla battitura o maciullatura per
separare la fibra dalla parte legnosa. Allo scopo si usa la “macenga” o gramola, un tronco d’albero
spaccato a metà, con la parte superiore che viene sbattuta su quella inferiore mentre si introduce il
mazzetto di piante. Si prosegue con la pettinatura facendo passare le fibre attraverso una fittissima
serie di chiodi sempre più piccoli. Questa operazione, molto faticosa e svolta tra la polvere, spesso è
eseguita da squadre specializzate di canepini, gente sempre assetata e dalla vita breve per via del
vino e della polvere.
La canapa e il lino, una volta puliti e raccolti in mannelle o fascetti (del tipo di quelli di capeccio
che vediamo usare oggi dagli idraulici), sono pronti per essere filati con la conocchia e il fuso, per
passare poi all’arcolaio (depenatò), al filatoio (filarellu), all’orditore fino alle spole (vùcini) per il
telaio domestico.
L’importanza della canapa e del lino nell’economia domestica contadina e in quella generale è
testimoniata dalle diverse inchieste che dal tempo di Napoleone sono state condotte nella zona: da
quella del 1811 risulta che in quasi tutti i paesi del Dipartimento del Tronto (grossomodo le attuali
province di Ascoli Piceno e Fermo) sono occupate nella produzione di tele bianche casarecce “un
gran numero di individui”, “centinaia di donne”, dal momento che “ogni casa quasi generalmente
s’industria in simili oggetti… nel filare e tessere”. L’inchiesta del 1892 conta 3124 telai casalinghi
nel Fermano.
Il panno prodotto in casa e sbiancato o curato attraverso ripetuti lavaggi al fiume ed esposizioni
al sole, è ben arrotolato e conservato nella cassa. Esso, sotto forma di rotoli e di biancheria, andrà a
costituire il corredo delle figlie. Altre pezze, tinte in casa o in paese, servono per camicie, gonne,
pantaloni, giacche, ecc. confezionate dalle stesse donne contadine o, spesso, da una sarta o sarto di
paese che si reca nelle case di campagna.
Il commercio sia della canapa e del lino che delle pezze, mancando i negozi come oggi, si
svolgeva principalmente nelle fiere dove era possibile acquistare anche la bambacia ossia il cotone
che serviva a completare la gamma delle fibre tessili per le manifatture domestiche.
Per quanto riguarda le sorti di queste coltivazioni bisogna osservare che il lino era di gran lunga
il più amato dai contadini. La ragione è sempre la stessa: questa pianta, oltre alla fibra, dà un seme,
“di cui al padrone tocca pochissima parte” come dice il Valeriani agli inizi dell’Ottocento, che
alimenta un florido mercato semiclandestino. Un seme al quale sono attribuite virtù quasi
taumaturgiche ed è presente in molte ricette di medicina popolare. I semi di lino immersi in acqua si
gonfiano diventando mucillaginosi; l’impasto, scaldato, è posto su qualsiasi parte dolente a sollievo
dei dolori; con la farina si approntano cataplasmi nella cura delle bronchiti, di foruncoli e bubboni
di varia natura; il decotto viene bevuto contro il mal di stomaco o di reni ed è raccomandato come
emolliente, lassativo e antiflogistico; posto in infusione, poi, la sua acqua si fa bere ai bambini
contro i disturbi intestinali. Non solo, macinato e spremuto al frantoio, il seme di lino fornisce olio
in ragione del 30-40%, olio utilizzato nella preparazione dei colori, delle vernici, degli inchiostri da
stampa, in falegnameria ma anche in medicina e veterinaria. I panelli residui della molitura sono poi
un buon mangime per i bovini.
A partire dalla metà dell’Ottocento, però, i proprietari si fanno più attenti alle rendite e
cominciano a proibire la coltivazione del lino in favore di quella della canapa, considerata più
remunerativa: nonostante la diffusione del cotone a bassi prezzi, infatti, la canapa ha ancora un
discreto mercato per lo sviluppo delle manifatture di reti e di corde a Porto San Giorgio e a San
Benedetto. L’arrivo delle fibre sintetiche in questo secondo dopoguerra segnerà, però, la fine anche
della coltivazione della canapa.
(Luigi Rossi)